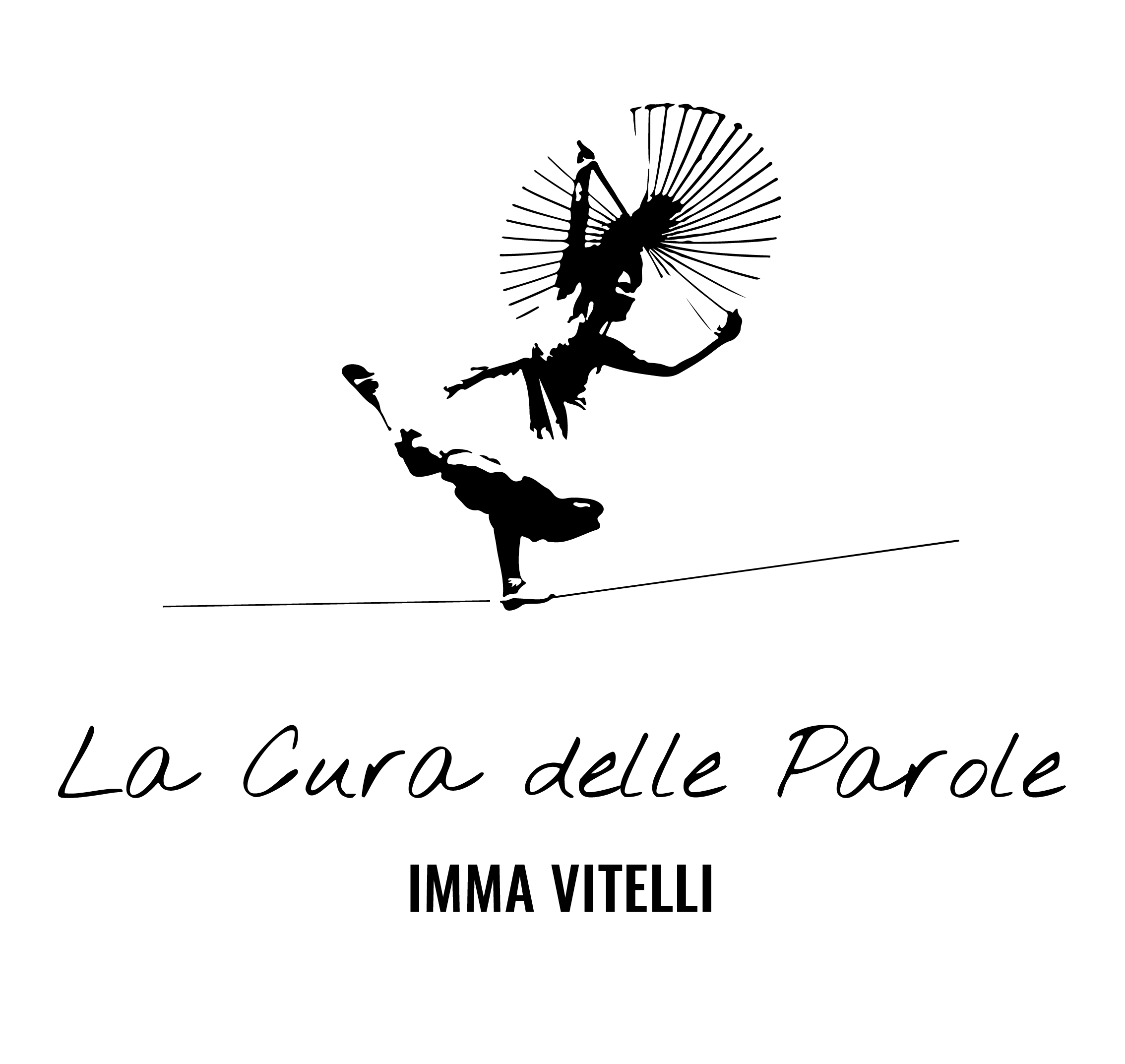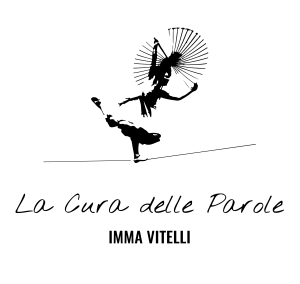23 Dic Nella Betlemme africana
Una notte di Avvento, a Lalibela, i canti cominciarono all’una, e nelle valli buie echeggiò il suono dei tamburi e dei sistri. In chiesa, si accalcava una lacera fiumana, di mamme smunte coi neonati sul dorso, di contadini e pastori, avvolti negli scialli chiari.
C’era chi aveva camminato per un paio di giorni, o forse due millenni, tra impervi sentieri; riposava ora all’ombra dell’altare. Mi colpì, in un angolo, un cumulo di stracci. Riconobbi il profilo di una donna, le spalle scosse da una forza misteriosa.
“Ha dentro il demonio”, commentò serafico la mia guida, Destaw.
Il sacerdote, imponente e ieratico, brandiva una croce d’argento e declamava versi del Nuovo Testamento: “Quello ch’io vi dico nelle tenebre, ditelo voi nella luce”.
La sua voce rimbombava tra i calanchi, oltre il fiume Giordano, grazie a un megafono, rara concessione alla modernità delle alte sacre terre degli amara.
Non so quanto tempo rimasi ipnotizzata lì dentro. Ricordo i canti e i respiri e le candele, una melodia perduta, un’intima pastorale.
“Li senti gli uccellini?” chiese a un tratto Destaw.
Era un giovane diacono, alto e dritto e forte come un bue.
“Annunciano una nuova luce. E’ mattina, a Lalibela”.
Di Lalibela, e delle sue meraviglie, mi aveva parlato un amico di Nairobi. Si discorreva di croci e mezze lune; gli dissi che non c’era più fede, nelle chiese, ed egli replicò tranchant: “Parli così perché non sei mai stata a Lalibela”. Avevo studiato, allora, e letto di questo stravagante re sacerdote che nel 1100 aveva costruito, in 24 anni, “con l’aiuto degli angeli che hanno lavorato di notte” una replica di Gerusalemme in Abissinia: 11 chiese scolpite nella viva roccia, 11 incantevoli grotte dedicate ai santi e agli apostoli. Avevo visto foto e letto libri, scoperto che l’Etiopia era stato il primo paese africano ad abbracciare Gesù, convertito nel IV secolo da due monaci levantini di Tiro.
Ma niente poteva prepararmi a questo viaggio di pesti e vergini, a questo cantico nel paradiso e nell’inferno del cristianesimo delle origini. Per arrivare a Lalibela, nel Nord dell’Etiopia, ho preso un aereo per Addis Abeba, la capitale, ed ho percorso 750 chilometri di vaste brughiere che a un tratto si impennavano in maestose alture di pietre.
Il nostro lento andare era sovente interrotto dal traffico del bestiame, e da bimbi scalzi e lerci che alla nostra vista urlavano: faranji, stranieri!
Il tempo si era fermato da qualche parte, intorno al Medioevo, e anche il paesaggio mi sembrò indeciso tra la leggiadria dell’Africa e l’asprezza dell’Arabia.
Le donne erano tenaci puntini sui contrafforti assolati, dignitose nel passo, curve sotto il peso del legname. Gli utensili erano di pelle e di legno e di pietra, e il fuoco per abbrustolire i cereali ardeva sul prezioso sterco degli animali. La vita era appesa al raccolto e alla pioggia, poiché i fieri amara non avevano ancora asservito la natura costruendo canali. La gente era ancora convinta che la terra fosse piatta, un quadrato, o al limite un cerchio, e che l’alternanza del giorno e della notte fosse causata dalla rotazione del sole intorno al nostro astro.
Eravamo ormai a 2600 metri quando su un fianco del monte Abuna Josef apparve all’orizzonte un leggendario tavolato, un lungo e squadrato frammento di cobalto.
“Benvenuti in paradiso”, fu il saluto di Destaw Yismaw, la mia preziosa guida. Destaw aveva 29 anni ed era a tutti gli effetti parte della casta sacerdotale al potere da tempo immemore sugli altipiani. Lalibela, la città santa, la nuova Betlemme, il Vaticano di un Gesù scarlatto, aveva 11 chiese e 1000 preti su 30.000 abitanti.
L’appartenenza alla casta era per lo più ereditaria, nella chiesa ortodossa copta il clero si può anzi si deve sposare.
Pur essendo figlio di sacerdote, Destaw non ce l’aveva fatta. “Resterò per sempre un diacono”.
Sedevamo in cima a un’altura, sopra un cimitero, uno di quei mucchi di pietre che difendono i morti dalla fame delle jene.
Gli chiesi spiegazioni. “La regola è questa. Per diventare prete, un diacono deve sposare una vergine, e non può divorziare. Io una vergine l’ho sposata, ma mi ha lasciato”.
E come fa un diacono aspirante prete a esser certo che la prescelta sia illibata?
“Le scegliamo giovani, di dodici, tredici anni. Mia moglie ne aveva 14”.
E fu così che mi ritrovai, il giorno dopo, a parlare della vita sessuale dei sacerdoti copti nella fantasmagorica Chiesa di San Giorgio. Wedaynew Asefa aveva 61 anni e gli occhietti furbi. Sedeva regale davanti ai drappi rossi che coprivano l’altare e allungava la sua grossa croce d’argento ai fedeli che si chinavano a baciarla.
“Certo che un diacono deve sposare una minorenne!” fu l’esordio.
Mi guardò come se gli avessi chiesto se al mattino il sole sorge.
“Come altrimenti le troviamo le vergini?”
Che la domanda non fosse retorica, lo scoprii qualche giorno più tardi, all’ospedale.
Era, in realtà, un agglomerato di quattro prefabbricati, ai piedi della collina, con cinque giovani medici spediti dalla capitale a servire una provincia di 250.000 abitanti.
Non c’erano medicine, e non c’erano i raggi e se qualcuno ti dava, ubriaco, una botta in testa, cosa che succedeva non di rado, ti ritrovavi a morire nel prefabbricato.
Ma il lato oscuro di Lalibela, mi confessò la dottoressa Etsub, era un altro: “L’aids che dilaga”. C’erano diecimila casi, un numero altissimo, anche rispetto alla media nazionale: “La gente è analfabeta, e litiga, e beve, e mastica qat e non si regola”, spiegò la dottoressa.
“Altro che città santa, lo spirito qui si è dato”.
Nella chiesa di San Giorgio, quella a forma di croce, quella che la vedi dall’alto scolpita nella terra e ti sembra un’illusione ottica, padre Asefa aveva preoccupazioni più prosaiche.
A Lalibela, spiegò, ci sono 400 diaconi. Un diacono per celebrare la messa è obbligato a sposarsi.
“Se il diacono non sposa una vergine, la chiesa si estingue”.
Per questo, aggiunse l’uomo, quando la prescelta ha dieci anni, i genitori del diacono si recano dalla famiglia e chiedono: “Vostra figlia è vergine? Se lo è in quattro anni si fanno le nozze”.
Mi scusi, chiedo, ma non è illegale maritare una bambina?
Wedaynew Asefa agitò un codino di cavallo, scacciò la domanda come fosse una mosca.
“Il governo dice che è illegale. Ma noi abbiamo le nostre leggi”.
Rise, caustico. “Due anni fa, ho maritato mia figlia di 12 anni. Il governo mi ha portato in tribunale. Hanno stabilito che mia figlia può andare a vivere col marito a 17 anni”.
Il sacerdote scosse la testa, ed era chiaro il suo pensiero: non erano affari dello stato e neanche i miei.
Cambiò discorso: “Dica a tutti di venire a Lalibela”.
E certamente, pensai. Per i soldi del turismo. La chiesa copta si era arricchita con i biglietti degli ingressi; la visita alle chiese rupestri costava 50$ a testa.
“Dica a tutti che questo è un posto speciale”, insistette Wedaynew Asefa.
“A volte chiudo gli occhi e vedo l’eden”.
E com’è l’eden?
“E’un buon cibo, è un buon profumo, è un come sogno”.
Il giorno dopo all’alba, ebbi davvero l’impressione di muovermi in un’altra dimensione.
La strada che ci separava dal monastero di Neakutolaab era tutto un digradar di monti e terrazze, sotto un cielo roseo così delicato che sembrava di polvere. Avevo fatto amicizia con Abebe Abebaw, il sacerdote custode della grotta, ed egli mi aveva parlato di angeli e di miracoli e di esorcismi.
“Ne vuoi vedere uno?” mi aveva chiesto serafico.
Nella Chiesa di San Gabriele, la prima notte, mi era rimasta impressa la donna seduta per terra di fianco all’altare, gli occhi incavati, le spalle in tumulto. Avevo visto il prete toccarle il capo e il petto con la croce e mormorare il padre nostro fino a quando la donna si era placata, ma più che a un esorcismo, la scena mi aveva fatto pensare all’ipnosi.
Ora padre Abebaw mi stava offrendo un’altra possibilità. Dentro, in chiesa, la gente era in fila per ricevere la benedizione e portarsi a casa otri di acqua santa che cadeva, goccia a goccia, dalla montagna dentro piccole vasche naturali. Padre Abebaw si fermò in un piccolo slargo, un orlo su un precipizio, brandendo una croce gigante sul corpo seminudo di un giovane di 18 anni. Intanto un suo aiutante inondava il ragazzo di acqua santa da una grande tanica gialla. Non mi parve un esorcismo e neppure un battesimo, piuttosto un tentativo di affogamento.
“Aveva dentro il diavolo”, spiegò alla fine il sacerdote.
Chiesi lumi.
“Non veniva in chiesa, allora il padre lo ha legato e lo ha trascinato qui. Oggi sta meglio. Ha baciato la croce. Ieri si era rifiutato di farlo. Di solito ci vogliono 21 giorni per scacciare il maligno, e bisogna stare attenti: di solito aspetta alla porta”.
Il maligno?
“Certo”.
Più tardi, chiederò a Destaw, la mia guida, se sia comune legare le persone che non vanno a messa e portarcele con la forza.
“Certo! Altrimenti sono idolatri”.
La mia mente si fermò su quella parola: ero abituata a sentirla pronunciare da fanatici islamisti, ma era nello stesso tempo biblico che abitavano i cristiani etiopi.
Destaw spiegò che la chiesa copta aveva i nomi di ogni fedele. Chi non frequentava le messe e le cerimonie, chi non si faceva vedere, era fuori, scomunicato nei secoli e seppellito a 30 chilometri dalle sante sacre chiese di Lalibela. Un simile fato toccava anche ai credenti di altre religioni: musulmani, protestanti e cattolici avevano il diritto di calpestare il santo suolo ma non quello alla preghiera e neppure all’eterno riposo, quello dovevano cercarlo altrove.
Destaw era un uomo all’apparenza moderno: sotto gli scialli bianchi della tradizione indossava jeans e camicia. Eppure egli era un nastro registrato: non riusciva a rispondere alle domande che uscivano fuori dal suo seminato. In quel caso, si limitava a ripetere ciò che aveva imparato.
Una mattina, ci inoltrammo in uno dei tanti cunicoli che collegano le chiese, ma questo – spiegò Destaw – era diverso: questa buca verticale nella terra era l’inferno. Avremmo dovuto attraversarlo al buio e in silenzio. Destaw non disse più niente, e io francamente non ero preparata alle tenebre che ci avvolsero spaventose né alla strettezza del passaggio: era davvero come farsi largo in una bara chiusa.
Dissi: “Accendo una luce”.
“Non puoi”, replicò Destaw.
“Ne ho bisogno!”
“Non puoi” ribadì calmo Destaw.
“Perché?”
“E’ la regola. All’inferno niente luci”.
Quando finalmente sbucammo in un ambiente circolare, con tenui buchi, ebbi una reazione di fastidio, come al cospetto di un rituale morto, di un copione frusto, di un biblico teatro.
Mi vennero in mente le monache e i monaci e tutti i sacerdoti ai quali avevo chiesto il loro personale significato del Natale. Tutti, dal più alto al più umile, mi avevano ripetuto la stessa storiella, allo stesso modo, con gli stessi accenti apatici.
Adamo ed Eva hanno sbagliato, hanno disubbidito al Signore e così facendo ci hanno dannati. La nascita di Gesù ha corretto il loro errore e ci ha salvati. Era un mantra ripetuto a memoria come il Nuovo e l’Antico Testamento memorizzato dai bambini del seminario, i futuri diaconi, i cacciatori di bambine illibate.
Sedevano sulla terra rossa, sparsi come fiori, i vestiti laceri, i piedini scalzi afflitti da ferite purulente. Ripetevano i versi come avevo visto fare ai piccoli studenti delle scuole coraniche in Afghanistan, a testa bassa, sei ore al giorno, ogni giorno, per sei anni. Tra qualche anno, si ritroveranno tutti insieme, nella Chiesa della Vergine Maria, a celebrare l’Avvento. Indosseranno gli abiti della festa, completi di ombrellini damascati. Canteranno i salmi, tra i tamburi e i sistri, e scacceranno il Malvagio . E alla mezzanotte, le sei del mattino del 7 gennaio, secondo il calendario copto, accenderanno le candele di cera d’api, e quello sarà il segnale che il Bambino è nato.