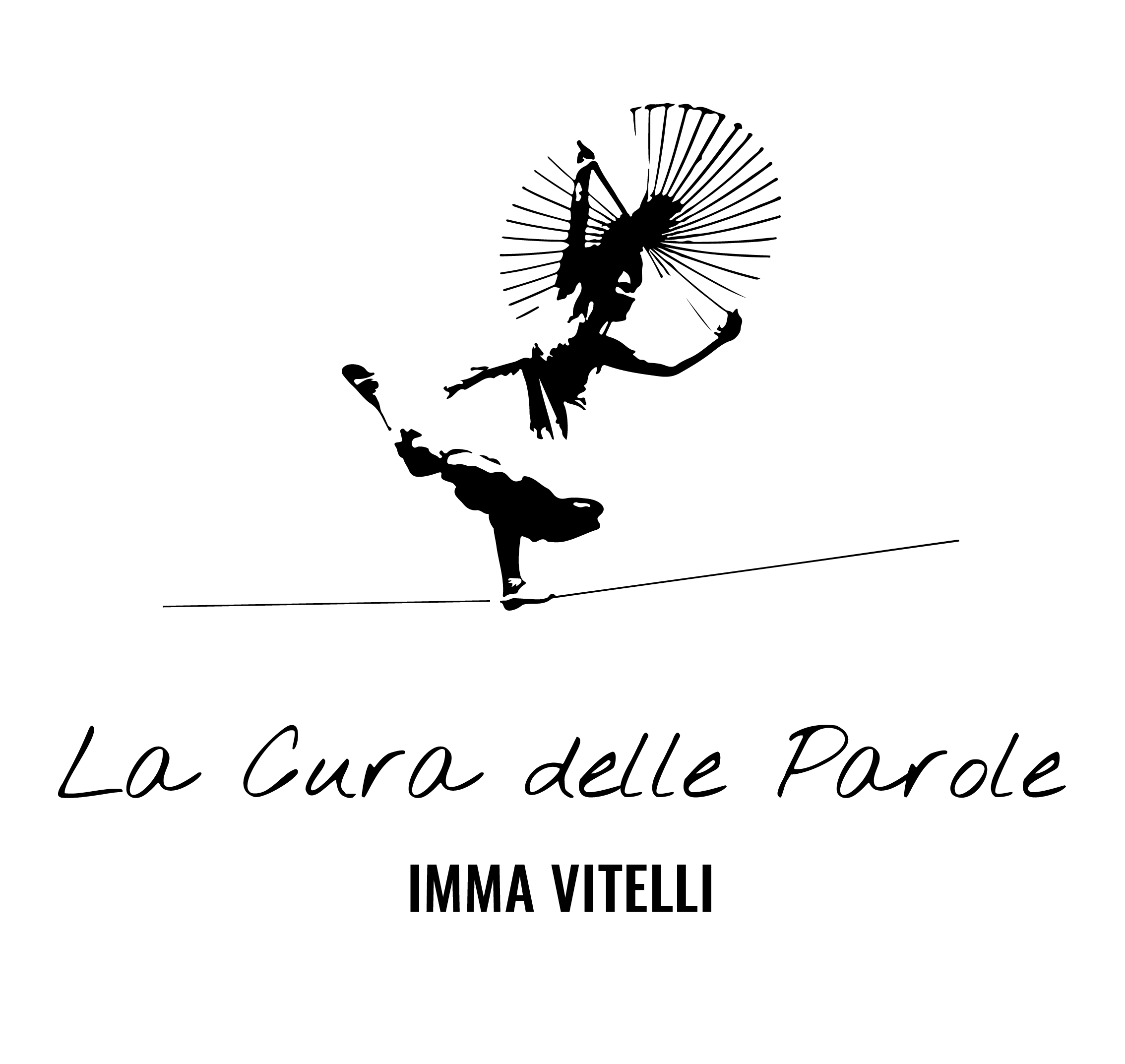29 Ott Hamra
Posted at 08:28h
in
Storie
by Frank Bonan
Avevo una gatta, a Beirut. Me la regalò un’amica, salvandola da una gabbietta su un marciapiede di Gemmayzeh. La chiamai Hamra, rossa in arabo, come il nome del mio quartiere, affacciato sulla mutevole immensità del mare.
Era, all’inizio, così piccola che quando dormiva, raggomitolata sul divano, il suo diametro era meno di una spanna. La sua fragilità era un inganno: nascondeva la sua natura di fiera combattente araba. Lo scoprii il giorno che venne a stare da me un’amica di Trieste assieme al suo micio, un siamese di nome Bambù. Bambù era un aristogatto della vecchia Europa, grigio di pelo, cauto nei movimenti, anziano d’età, castrato dall’infanzia.
Con Hamra conobbe una nuova terribile gioventù.
Accadde quando lei da puffa che era diventò femmina, avendo sconfitto i tentativi del veterinario di sterilizzarla, graffiandolo a sangue. Non mangiò mai la pappa con le gocce per dormire, e non permise mai al dottore di toccarla. Possedeva una misteriosa sapienza felina, e aveva subito stabilito che quell’uomo col camice era la tomba dei suoi desideri.
Mesi dopo, avrebbe dato un’altra dimostrazione della sua tempra: fu quando dal cielo piovvero bombe israeliane e lei, da brava libanese, perfezionò all’istante una personale tecnica di sopravvivenza, sgommando in due secondi dal terrazzo alla cucina, trovando rifugio in un anfratto dietro la lavastoviglie.
Quando venne il tempo delle voglie, e venne presto, prese ad emettere gorgoglii terrificanti. Si agitava sui tappeti del salone, mostrando furiosamente il sederino a Bambù o, in sua assenza, al muro.
Il nobile di Trieste reagì, a quei moti plebei, a volte con disgusto, arricciando i baffi e curvando la coda, a volte con terrore, battendo in ritirata sotto le gonne della sua padrona.
Presi a chiamarlo Cuor di Leone, consapevole di esser ingiusta. Eppure mi parve, la loro interazione, una parabola del nostro tempo: ci vidi tutta la confusione dell’identità di genere, tutto il disorientamento di chi si scopre dentro maschio e pure femmina; ci vidi, insomma, tutta la difficoltà di distinguere le femmine dai maschi, in tempi di femmine Mandrake e maschi efebi e depilati.
La mia amica suggerì che poteva anche essere una metafora dell’energia dei paesi in via di sviluppo vis a vis la stanchezza sterile dell’Europa post moderna; o forse la dissi io, questa cavolata, in verità non ricordo.
Ricordo molto bene, invece, il colpo di scena. Dagli e dagli, un giorno, nel blando petto di Bambù, affiorarono echi di remoti istinti virili. Lo vedemmo avanzare sul tappeto, dapprima incerto, all’improvviso impavido, coda all’insù, sguardo deciso, e avvinghiare Hamra da dietro alla ricerca di una qualche catartica unione. Provammo un’immensa pena nei confronti di un maschio che vuole ma non sa cosa e neppure come. E mentre eravamo concentrate sulla sua disfatta, quasi ci sfuggiva lo spettacolo della tigrotta libanese che, esasperata dall’aristogatto senza palle, sgaiattolava sul tetto a contemplare la luna.