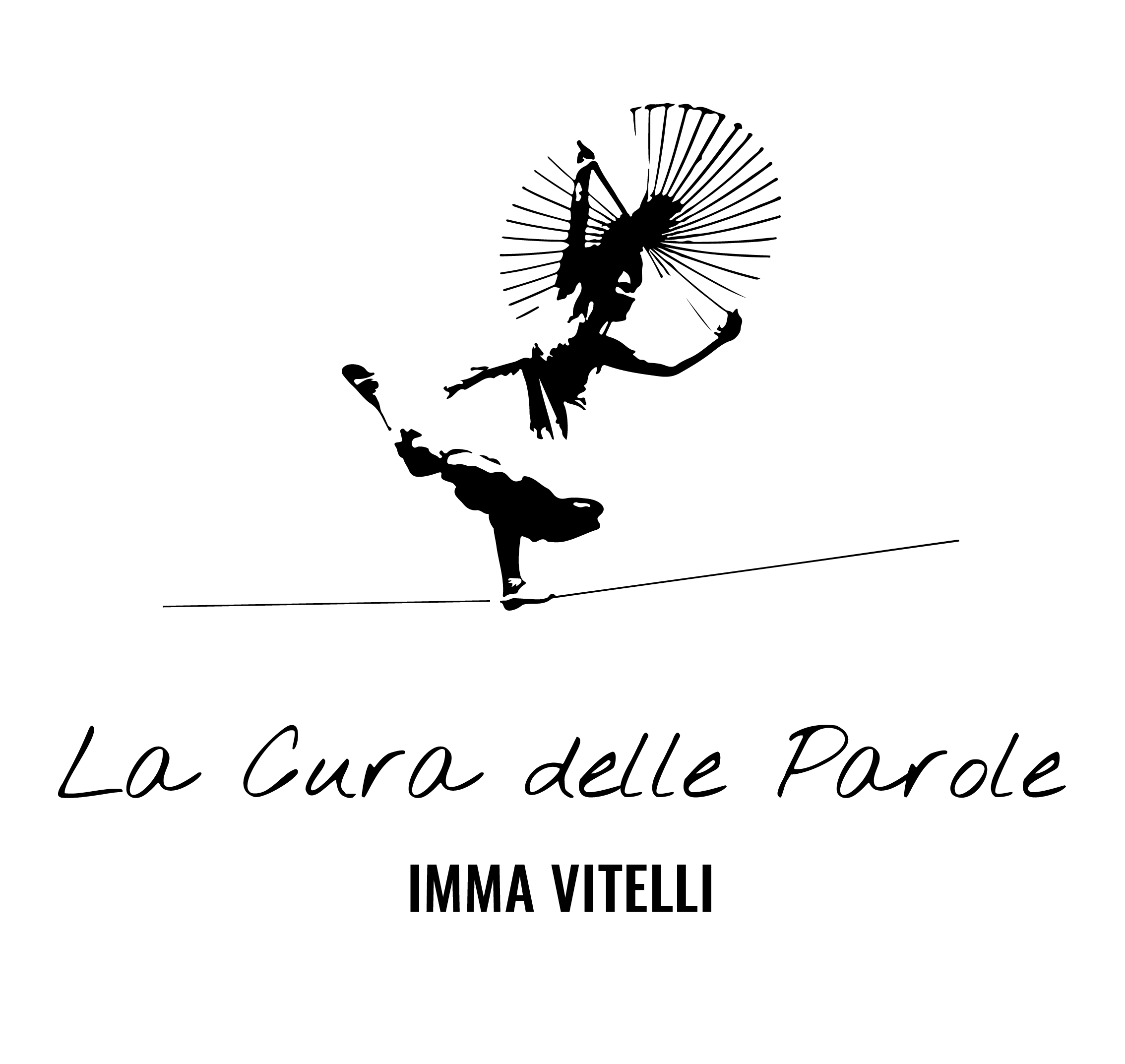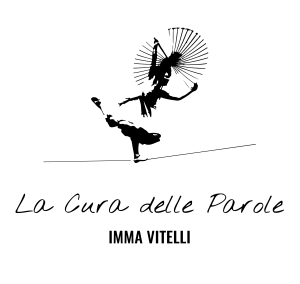24 Apr Karakorum Highway
Da qualche giorno, mangio di più, bevo di più, studio di più, e la sera crollo. Al mattino monto sulla cyclette con una ferocia degna di una gara e dopo lo stretching mi abbatto sulla poltrona alla ricerca di un libro che mi faccia pensare. E’ stato un mese intenso. Sono stata in vacanza in Pakistan. Cioè: per lavoro viaggio spesso in luoghi poco ameni, dormo per terra in scuole occupate da barbuti guerriglieri. Mi capita, talvolta, di non lavarmi per giorni e di solito, quando torno, non ho un odore diverso dai profughi che incontro.
E allora, benedetta ragazza, cosa diavolo mi vai in vacanza in Pakistan? In effetti, stavo per schiattare, dopo sei ore di trekking e mille metri di dislivello, sotto una pioggerellina infida, che mi appiccicava sulla fronte i capelli.
Maledicevo la mia imprevidenza, la stanchezza rende tristi e la mancanza d’ossigeno, a 4.500 metri, sparpaglia il cervello.
Avevo visto, a valle, tumultuosi ruscelli e floridi campi e alberi carichi di albicocche meli e mandorle; avevo concluso che il paradiso terrestre esiste, in un remoto Est, sulla Karakorum Highway.
Avevo mangiato uno yogurt burroso, denso, yum yum, puro latte di capra fermentato in un torrente ghiacciato e avevo maledetto nell’ordine gli inglesi e la rivoluzione industriale, il progresso e le pastorizzazioni europee.
Poi però, il corpo tiranno si era messo a reclamare una tregua e con grande coerenza volevo un letto e una doccia calda. Il cielo, anche, si era fatto grigio; ricordava il freddo sipario di un Dio scortese: fino a quel crepaccio inatteso.
C’era stata una luce, sul pendio a sinistra, e un candore: un’immensa bianca foresta di pietra, di picchi capricciosi, di canyon spaventosi, si stendeva ai nostri piedi. Era il ghiacciaio di Minapin: la nostra meta. Il nobile Rakaposhi, di 7.800 metri, giocava a nascondino con le nuvole. Faceva capolino per un minuto, sfuggente e remoto, e per un curioso riflesso, pensai di inventarmi una preghiera.
Un ruggito potente, sotterraneo, ricordava gli infiniti cambiamenti della natura: erano i fiumi creati dalla neve che si era fatta ghiaccio e che ora cambiava di nuovo stato ritornando acqua.
Rimasi lì, rapita, senza un dolore, in testa un punto esclamativo: “Ohhhhh!”
C’è qualcosa, nella natura, che redime; evoca l’innocenza dei bambini, l’estasi della poesia, che è sempre canto dell’eterno.
Ricordo mi sedetti, a un tratto silente. E che brindai con un calice d’aria alla bellezza e alle sue fatiche, sempre.