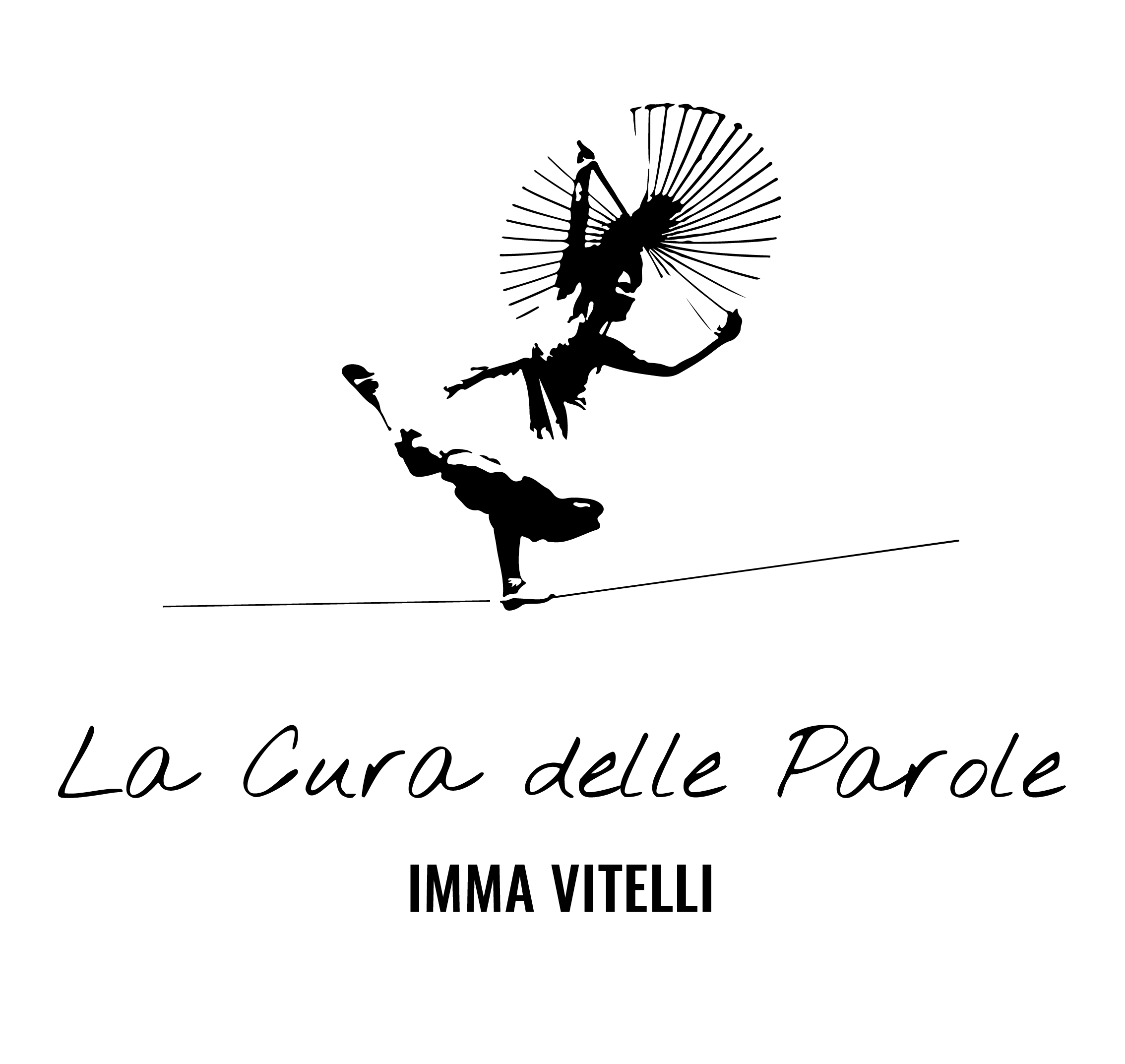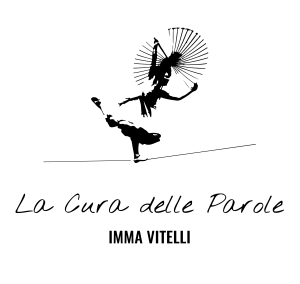12 Mar Shangri – La
Cercavo Shangri La. O, almeno, una durevole quiete. La trovai, alla fine del mondo, su uno spaventoso sentiero di ripidi picchi, assieme a un Budda vivente, bloccato come me da una ruspa, tra le rocce dell’Himalaya.
Avevo fatto così tanta strada.
Mi aveva fatto compagnia un libro del 1932, “Orizzonte perduto”, dell’inglese James Hilton; raccontava di un remoto e segreto monastero abitato da antichissimi saggi, custodi delle fragili eleganze di un’età moribonda, in attesa del cataclisma finale. Credevano, i saggi, assieme al popolo della valle da essi governato, in un solo principio: quello della moderazione, fonte di uno speciale grado di felicità. “Governiamo con moderata severità, e siamo soddisfatti di un’obbedienza moderata. La nostra gente è moderatamente sobria, moderatamente casta, e moderatamente onesta”, dice uno dei lama del tempio, chiamato Shangri La.
Il libro ebbe un successo enorme; qualche anno dopo Frank Capra ci fece un film altrettanto famoso. Recavano entrambi, in Europa e in America, nel mezzo delle due grandi guerre, un messaggio consolatorio, e molto buddista: che il dominio delle passioni è il principio della saggezza; che esiste, da qualche parte, in cima a una montagna, se si è disposti a scalarla, una dimensione che non tormenta e non annoia; l’importante è crederci, ed essere capaci di riconoscere le luci del porto, quando finalmente si profilano all’orizzonte.
Da allora, Shangri La è diventato un clichè, un anelito di massa, un paradiso troppo terrestre offerto a cinque stelle da una catena di alberghi, che ha stampato sui dentifrici e le creme e gli shampoo dei bagni brani di “Orizzonte perduto”.
Ma i più astuti sono, forse, stati i cinesi, che l’altopiano del Tibet, dove il romanzo è ambientato, occupano dal ’49: con un colpo di genio, hanno dichiarato al proprio popolo e al mondo, di sapere esattamente dove fosse questo paradiso: nella regione di Yunnan, nei dintorni di Zhongdian, che dal 2001 ha cambiato nome, diventando ufficialmente Shangri La.
Per arrivarci, in auto da Lijiang, attraversai foreste da fiaba punteggiate dalle Yak, le mucche tibetane. Nere, col muso bianco e le corna maestose, riposavano placide coi loro campanelli sul ciglio della strada; altre scalavano lente le montagne di betulle eucalipti e pini e altri alberi misteriosi, con delle foglie filanti.
In uno slargo della strada, una decina di monaci nelle tuniche arancioni sedevano pigri. Uno ascoltava la musica con le cuffie; il più anziano, Ziliduji, spiegava che eravamo vicini, la montagna alle sue spalle, si chiamava Shangri La. Cominciai ad avere l’impressione che fosse ovunque, e da nessuna parte. Ziliduji aveva una sua idea personale: “La felicità è una situazione in cui non devi lavorare, e ti riposi ogni giorno”.
Nella vecchia Zhongdian la gente sembrava davvero felice: antiche case di legno, cime innevate, e nella piazza Sifanq, quella principale, decine di persone a ballare la danza del Qinq, ovvero dell’amore. Lo facevano tutte le sere, al tramonto, giovani e vecchi, maschi e femmine, tutti assieme, alla ricerca, tra primitive note, nell’aria fresca della sera, di un compagno o di una compagna di vita.
Tutte queste cose me le spiegò Zho Ma, una signora dal volto antico, con una gonna azzurra e viola e un gilet ricamato di fiori. Le chiesi se conoscesse il significato del nome nuovo dato al suo paese, rispose che era un posto sacro, nella foresta: “C’è una leggenda, l’hanno trasmessa alla televisione. Di più non so, il nome esiste solo da qualche anno, però è una cosa buona, perché da allora arrivano turisti da ogni dove”. Zho Ma mi regalò un sorriso, poi disse che se volevo saperne di più potevo andare su in collina, al Tempio dei templi di Daguishan, lì forse avrei trovato delle risposte ai miei quesiti.
Il monastero era un cono d’oro, e dominava la città antica. La sua immensa cupola era visibile da ogni vicolo; dentro riposava una statua del Siddharta, il principe che 2500 anni fa, nel Nord dell’India, fondò il buddismo. Tra i rulli della preghiera, si aggirava uno dei monaci, Lozam Delei. Mi offrì un te nella sua celletta. Mi spiegò di far parte della branca gialla del buddismo tibetano; le altre erano rosso, bianco, nero e cielo.
Chiesi: “E Shangri La?”
“Shangri che?”, rispose.
Poi finiì tra le luci soffuse di un bar della città vecchia, e la mia ricerca fece un balzo in avanti. C’era Internet senza fili, c’è dappertutto in Cina, è stupefacente, un po’ come la storia che mi raccontò Kersan. Era tibetana e bellissima, con un volto da Madonna del Botticelli. Beveva te col latte di Yak, col sale. Sapeva del libro di Hilton, l’aveva letto. Disse: “Io ci sono nata, vicino al monastero dei Saggi”. La sua famiglia viveva ancora nella valle Azzurra, tra le montagne sacre di cui parla il romanzo; c’era un motivo se un inglese aveva pensato che quella terra, la sua, fosse un paradiso: “Lo è. E’ così bella”.
Dall’altra parte del divano, un suo amico, Li Hu, fotografo di Pechino, fece si col capo; era innamorato del Tibet e della valle Azzurra, che visitava spesso.
“Shangri La è un sogno”, disse. “Le persone lì vivono in armonia, sono gentili gli uni con gli altri. La gran parte di noi cerca a lungo un luogo così, senza trovarlo. Loro ce l’hanno. E’ isolato, e quindi non può essere contaminato dalle altre culture. Il buddismo tibetano ha lì la sua rappresentazione più pura. E’, davvero, come nel libro. Prima dell’occupazione cinese, non c’era un governo, per cui la gente si auto regolava seguendo i consigli dei lama. E poi sono speciali anche all’interno della cultura tibetana. Hanno una struttura famigliare che non ha eguali al mondo”.
Disse Kersan: “Io, per esempio, ho tre papà”. Nel senso che sua mamma aveva sposato tre fratelli. Era comune, lassù. Così, non si divideva la proprietà. Così, si viveva tutti assieme. Senza gelosia? “Gelosia?”, m’interrogò Kersan. “E cos’è?”
Seguendo le loro indicazioni, partimmo per le vertigini dell’Himalaya, in direzione Failai, molto dopo Deqin, nel cuore del Tibet. Al mattino, il villaggio si svegliò sopra le nuvole, immensi batuffoli bianchi galleggiavano intorno alle montagne, infiocchettate di preghiere colorate. Nell’aria rarefatta, i fedeli accendevano bastoncini di incenso porpora e viola, e pregavano, inchinati verso una visione lontana e inaccessibile, quasi vergine di impronta umana: la montagna di Neve Meili, la montagna sacra, il Karakal di Orizzonte Perduto.
Hong Po Si, il monastero che poteva o non poteva essere Shangri La, era oltre, a un paio d’ore, su una strada senza nome.
Mi avevano detto che il cammino era difficile. Che il tempio della Saggezza era da qualche parte, isolato. Dubitai di riuscire a trovarlo. Conclusi che prima di arrendermi l’avrei cercato, e ricercato. Poi successe la prima cosa strana.
Solo e sparuto, sulla via deserta e remota, seminudo nel freddo dell’autunno inoltrato, un monaco ci chiese un passaggio. Si chiamava Lubuzili. Indossava, sulla tonaca, un cappello blu dell’Adidas. Andava diritto dove speravamo di arrivare noi: a Hong Po Si. “Volete che vi faccia da guida?” Pensai: chi ti ha mandato? Disse: “Sto ritornando a casa, vivo lì”. Gli chiesi se era vero che il suo monastero fosse Shangri La. Scosse le spalle. Gli chiesi cosa significasse per lui Shangri La. Disse: “Significa bello”. Bello? “Bello come un fiume, come una cascata”.
Lubuzili era tibetano, e il cinese, anzi il mandarino, lo parlava male. Però si faceva capire bene quando voleva: aveva bisogno di ricaricare il cellulare, era forse possibile fermarsi per strada?
Così, sulla strada per il paradiso, ci fermammo a comprare una ricarica, a Yunlingxiang, una radura di basse casette, sul gomito di una curva. Dentro una di queste casette, un vecchino, seduto su una branda di legno si faceva, seduto, una flebo. Alle sue spalle, in quel che era l’ambulatorio della frazione, c’era il listino prezzi: “Un parto: 300 yuan; due parti: 420; un aborto: 240; un parto con complicazioni: 480”.
Ripartimmo, e il Tibet in tutta la sua poesia si offrì al nostro sguardo: campi di mais e alberi da cui piovevano albicocche; strade sterrate, una sinfonia di ruscelli e, infine, su un cucuzzolo sperduto, uno spettacolo affascinante: un gruppo di edifici colorati, in cima a una gola di roccia, con la grazia di petali sparsi, intorno a un monastero.
Ci vivevano 56 monaci, e quattro lama. C’erano i lavori in corso: stavano ingrandendo il tempio, e costruendo una nuova casa per il Budda Vivente, una figura santa, una reincarnazione del Budda, che garantisce la continuità del governo del Dalai Lama.
Egli, però, non c’era, era sceso giù a valle, a pregare con la gente del villaggio. A fare le sue veci, fu
Nawanshili, il monaco più anziano, di 79 anni, con una faccia serena, giocosa perfino. Viveva lì, tra i rododendri e le azalee, da quando ne aveva 15. Gli chiesi se fossi, finalmente, arrivata a Shangri La. Sorrise. “Mah… ne abbiamo sentito parlare per la prima volta tre o quattro anni fa. E’ stato il governo cinese a dirci che è qua”. Spiegò che “Shan” voleva dire profumo e “Gri” dentro: “Significa che l’uomo deve essere buono dentro e fuori”. E che vuol dire? Il vecchio monaco sorrise di nuovo, i suoi colleghi più giovani pure. “Significa che devi trattare gli altri in maniera eguale, a prescindere dalla ricchezza”. Poi mi invitò ad aspettare Luzong, il Budda Vivente: sarebbe arrivato nel pomeriggio, ma io scalpitai, realizzai di scalpitare, mi chiesi se fossero loro, gli orientali, lenti, o noi, occidentali, esagitati; così diverse sono la loro e la nostra cognizione del tempo. Alla fine, non aspettai, dissi che sarei tornata, presi un appuntamento.
Non avevo fatto i conti con gli orridi tornanti e stupefacenti gole che ci aspettavano sulla via del ritorno. La salita, al confronto, era stata una festa; la discesa, giù a valle, si rivelò un film dell’orrore. Vertiginosi picchi, curve e calanchi e ripide gole, un abisso spaventoso, che mai più avrei attraversato.
Dissi addio a Shangri La e addio, pure, al mio appuntamento, ma ero stata, ancora una volta, precipitosa: fu allora che successe una seconda strana cosa. Sul bordo di un burrone, nella valle della Luna, al cui fondo scorreva grigio il Mekong, una ruspa bloccò il nostro accidentato cammino. Faceva a pezzi coste di montagna affinché le coste della montagna non facessero a pezzi noi. Riduceva, insomma, il rischio di slavine. Eravamo, sospesi sul burrone, e sul Mekong, e sulla valle Azzurra, bloccati da un’ora, quando, oltre la ruspa, vidi, dalla parte opposta, avanzare un’auto, con dentro un monaco.
Scesi dalla jeep, scavalcai la ruspa, avanzai sul precipizio, e scoprii che l’uomo arancione che sedeva serafico e composto, dietro un paio di occhialini, era lo stesso cui avevo detto silenziosamente addio: il Budda Vivente. Pensai al libro “Orizzonte perduto” e mi sembrò, nel crepuscolo, la personificazione di quelle luci del porto cui volevo approdare.
Gli dissi che la ricerca mi aveva estenuata. Disse: “Forse sta cercando nella direzione sbagliata”. Si toccò il petto con la mano: “E’ qui che devi cercare”.
Dissi: “Vengo da una regione in guerra, e aspiro alla pace”.
Rispose: “Non importa dove sei. Si può essere in pace, anche in guerra”.
Chiesi: “Come?”
Mi rispose con il titolo di una canzone dei Beatles: “Non prenderti sul serio. Let it be”. Lascia che sia. Mi stava ricordando l’essenza del suo credo: una religione senza Dio, in cui il sentiero per Shangri La ce lo portiamo dentro.