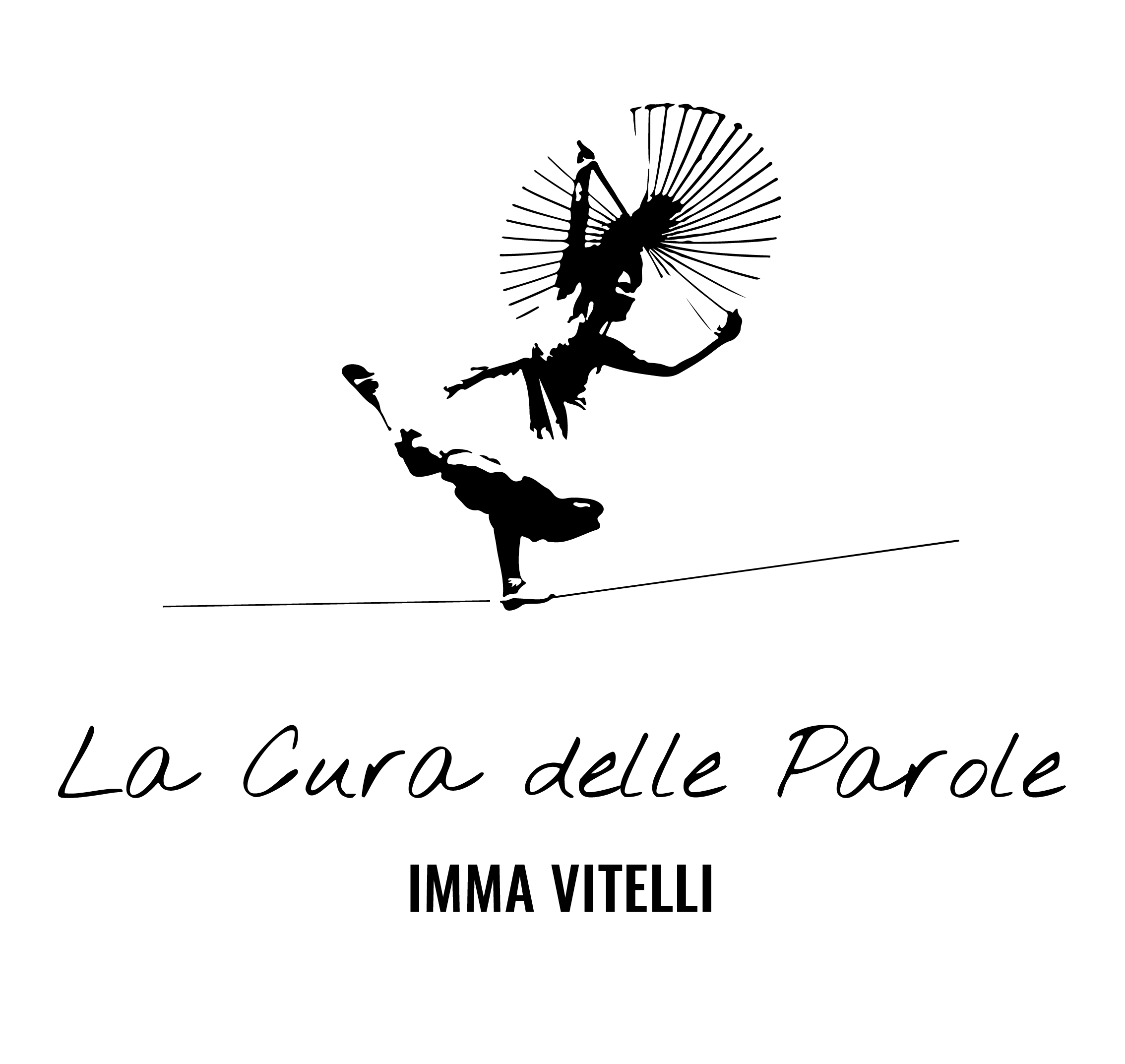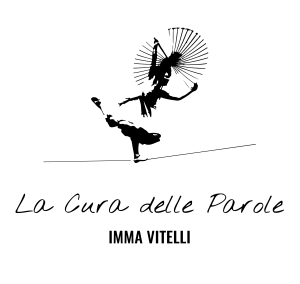12 Gen Sul bund
Ci eravamo incontrati nell’atrio di un albergo di Shanghai. Era arrivato, indolente, la faccia da indio, gli stivali da cowboy.
“Una birra?”
Non l’avevo mai visto, prima. Non avevo mai detto si, prima, a uno che non avevo mai visto prima. Venivo da un lungo inverno; ero stanca di portare il mio peso; stanca, anche, di sentirmi un’estranea.
Tutto ciò che volevo era che un uomo mi prendesse la mano.
Salimmo in cima a una torre sopra le nuvole con un razzo di ascensore; era un albergo futuristico, sul Bund.
Fu lì che annusai la prima volta il suo odore.
Parlammo delle cose di cui parlano i corrispondenti di guerra.
Lui raccontò dei cadaveri di Timor Est e di quel giorno in un obitorio di Roma a riconoscere i resti del suo migliore amico caduto in Bosnia. Io gli dissi di Al Qaeda e degli americani e degli israeliani e degli hezbollah e di come avevo imparato a pisciare in una bottiglia di plastica nei pressi di Tora Bora per non farmi impallinare dai Talebani.
Brindammo, sopra le nuvole, alla vita.
Mi chiamò sunshine.
Gli presi la mano.
Mi baciò i capelli.
Lo rividi settimane dopo in una pensione infame sul lago Vittoria.
Eravamo gli unici due bianchi di Kogelo.
Capii, per la prima volta, come devono sentirsi i neri nella nostre città bianche: perduti.
Cercai il suo sguardo, lui disse va tutto bene, fece uno strano inchino, con le mani, e col capo. Aveva il volto imperturbabile; mi fece pensare a un fiume arido.
Quando, più tardi, finimmo a letto, pioveva sui tetti di lamiera della pensione Lor.
Dopo, non dissi niente, era troppo tardi per spostare indietro le lancette.
Non eravamo stati in due, non lo si è mai, pensai; quella stanza era piena dei nostri spettri.
Mi aveva lasciata sola, col mio vuoto, ad ascoltare il temporale.
Rimasi in silenzio a fissare il muro, a neutralizzare un vago senso di colpa.
Mi chiesi perché avessi scelto lui. Mi piaceva il suo odore, ma era un essere ombroso, non più il mio tipo. Non era particolarmente brillante, e aveva per qualche ragione deciso che essendo bello, di una bellezza cinematografica, spigolosa, era imperativo che si occupasse di cose serie, come il consiglio di Nicea del 325 con il quale i cristiani, spiegava serio, provarono a risolvere la questione fondamentale della natura di Gesù.
Conclusi di essere stata sedotta dai miei stessi desideri.
Mi dissi congratulazioni, darling, sei cambiata, hai fatto uno sbaglio nuovo.
Mi chiese, di punto in bianco, se avessi un uomo.
Dissi di no.
Chiese: “Che stiamo facendo?”
Dissi: “Non lo so”.
Chiese: “Che significa?”
Dissi: “Quello che vogliamo”.
Chiese: “Cosa vuoi?”
Dissi: “Essere felice”.
Chiese: “Come si fa?”.
“Non lo so, ma voglio scoprirlo”.
Da quando ho scritto queste righe sono passati dodici anni, e molte cose sono cambiate. Ho smesso di viaggiare prima del virus. Alla finestra c’è il lago, in giardino quarantadue tartarughe. Non mi sento più un’estranea, forse perché pratico l’arte di essere chi sono. Forse è questa, la felicità. Essere se stessi, con umiltà, ogni minuto.
Beirut, 2008