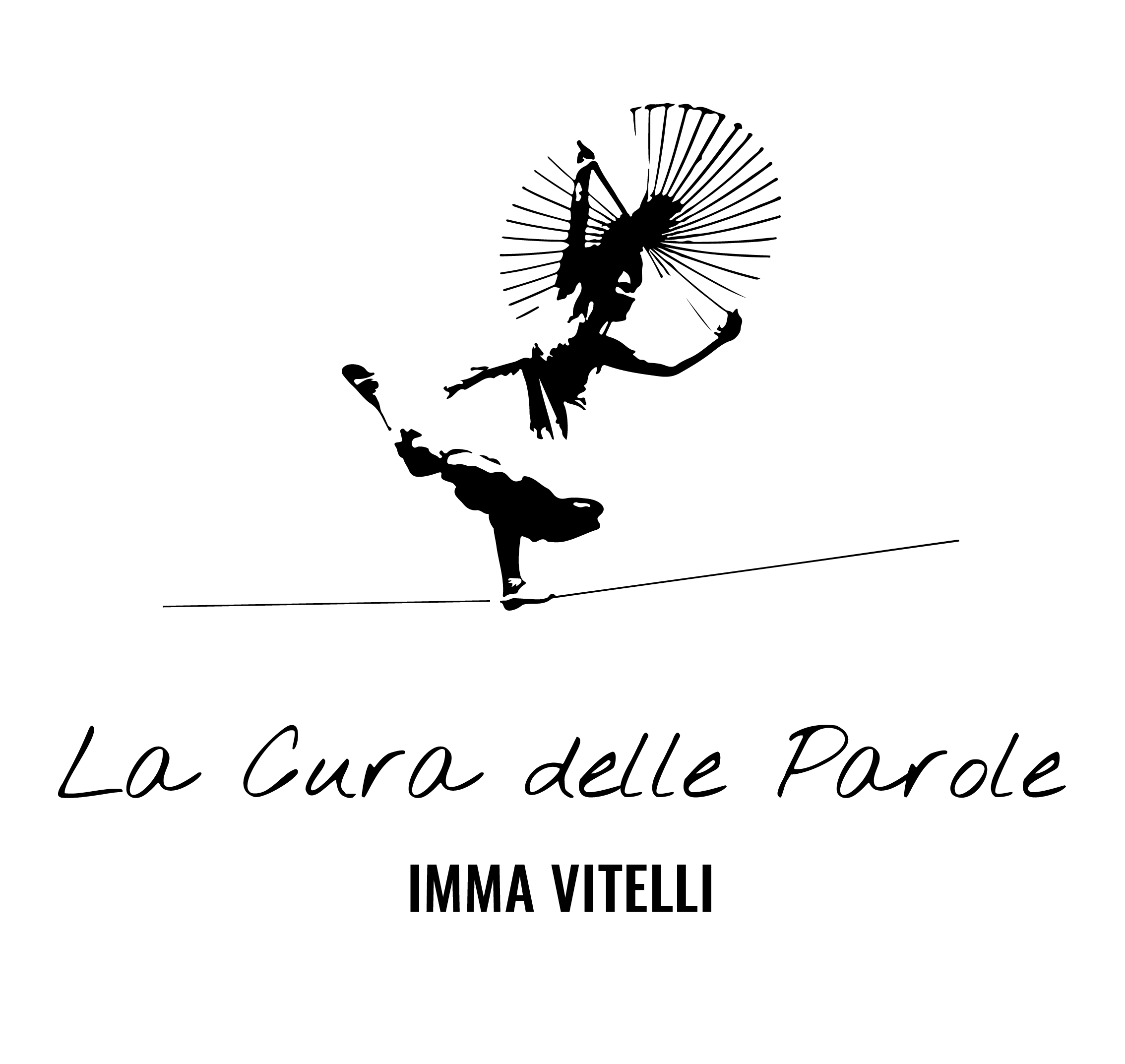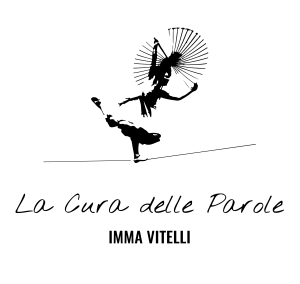05 Nov La stanza numero tre
Alloggiavo nella stanza numero tre sull’Oceano Indiano, a Nosy Be. La stanza era una capanna di un piccolo hotel, di nome Belvedere, su un promontorio spettacolare che dominava la spiaggia Andilana.
La proprietaria del Belvedere aveva capito tutto.
Si chiamava Virginie, aveva 60 anni e sangue misto metà del Madagascar, metà del Vietnam. Portava grosse trecce bianche, e parlava molte lingue, con la nonchalance di chi ha molto vissuto e nulla rimpiange.
“Quanto ti fermi?” chiese in italiano, che poi divenne inglese, con parole in francese e accenni di spagnolo.
“Non lo so”, risposi assorta.
Non avevo voglia di tornare alla base, ma non ero ancora disposta ad ammetterlo.
Volteggiavo nella nebbia psichica delle donne che s’innamorano e smettono di pensare.
Virginie accettò la mia vaghezza con un sorriso.
Sere dopo, m’invitò a cena nella sua capanna, la numero 10: “Qualcosa devi pur mangiare”.
Aveva i fornelli in veranda, e cucinava in compagnia di piccoli draghi ascoltando Bach.
Preparò dei granchi deliziosi e un altro grosso pesce misterioso; disse che aveva vissuto a lungo a Parigi con il marito ma poi qualcosa era andato storto.
“E’ andata così”, disse tranquilla.
Recava sul volto i segni del tempo, ma nei gesti e nella voce, faceva pensare a una saggia adolescente orientale.
“Con gli uomini che amiamo se ne vanno parti di noi. Ti va del vino?”
“Si grazie. Vale a dire?”
“E’ come andare a scuola”.
“A scuola?”
Virginie mi spiegò che le persone di cui ci innamoriamo e dalle quali poi fuggiamo ci aiutano a liberarci di parti che non sono nostre.
“L’egoismo di tuo padre, l’invidia di tua madre, tutta quella roba di cui ti devi spogliare per diventare finalmente te stessa”.
L’ascoltai pensando: ma chi l’ha mandata?
In camera, prima di cena, avevo riflettuto sulla solitudine.
Ci sono momenti in cui desidero la fusione: avete presente?
La simbiosi con un uomo, o con un Dio: con qualcun altro cui affidare le chiavi. Il desiderio infantile che sia un altro a pagare il conto e a chiudere il gas e a proteggermi dalle orde di nemici oltre la bolla, proprio lì, sulla soglia.
Virginie ora mi stava dicendo, a modo suo, che la vita è un ciclo continuo di baci e addii. Che la fusione vuol dire perdita di sé nell’altro, o assorbimento di sé da parte dell’altro: in entrambi i casi, è la scomparsa del soggetto, e dunque la morte.
Prima o poi, dobbiamo pur accettare la nostra incompletezza.
Quella notte, nella Baia di Andilana, ci fu una tempesta.
Il tetto della capanna numero tre era di foglie di cocco e quando il mare si arricciò e il cielo aprì le cataratte, presi un taccuino, e alla luce di una candela scrissi:
“FINE DELLA NEBBIA”.
Nosy Be, 2013